Albedo Newsletter - N°6
Ciao, questa è la newsletter Albedo, e io sono Sebastiano Santoro, scrittore di Duegradi. L’albedo è la capacità di un corpo di riflettere i raggi solari. I cambiamenti climatici stanno provocando, tra le altre cose, lo scioglimento dei ghiacciai; e la scomparsa di queste estese superfici chiare sta alterando l’albedo terrestre. L’obiettivo di questa newsletter è creare uno spazio condiviso in cui idee e informazioni sui cambiamenti climatici possano sedimentare e, allo stesso tempo, riflettersi e diffondersi un po’ ovunque, come i raggi solari quando colpiscono il nostro pianeta, appunto. Uno spazio utile perché quella che stiamo vivendo è un’epoca di cambiamenti, non solo climatici. Albedo cercherà di raccontarli, in tutte le forme possibili, dalla fiction alla non-fiction. E lo farà in cinque parti.
La prima è una sorta di editoriale;
la seconda è un consiglio di lettura;
nella terza, insieme alla redazione di Duegradi, cercheremo di rispondere ai dubbi e alle tue perplessità (scrivi qualsiasi cosa che ti salta in mente a redazione@duegradi.eu);
la quarta contiene link per offerte di lavoro e corsi di formazione, perché anche il mondo del lavoro sta cambiando;
l’ultima, la quinta parte, è un tentativo di misurare in cifre i cambiamenti che stiamo vivendo.
Maurice Spikes e l’uragano
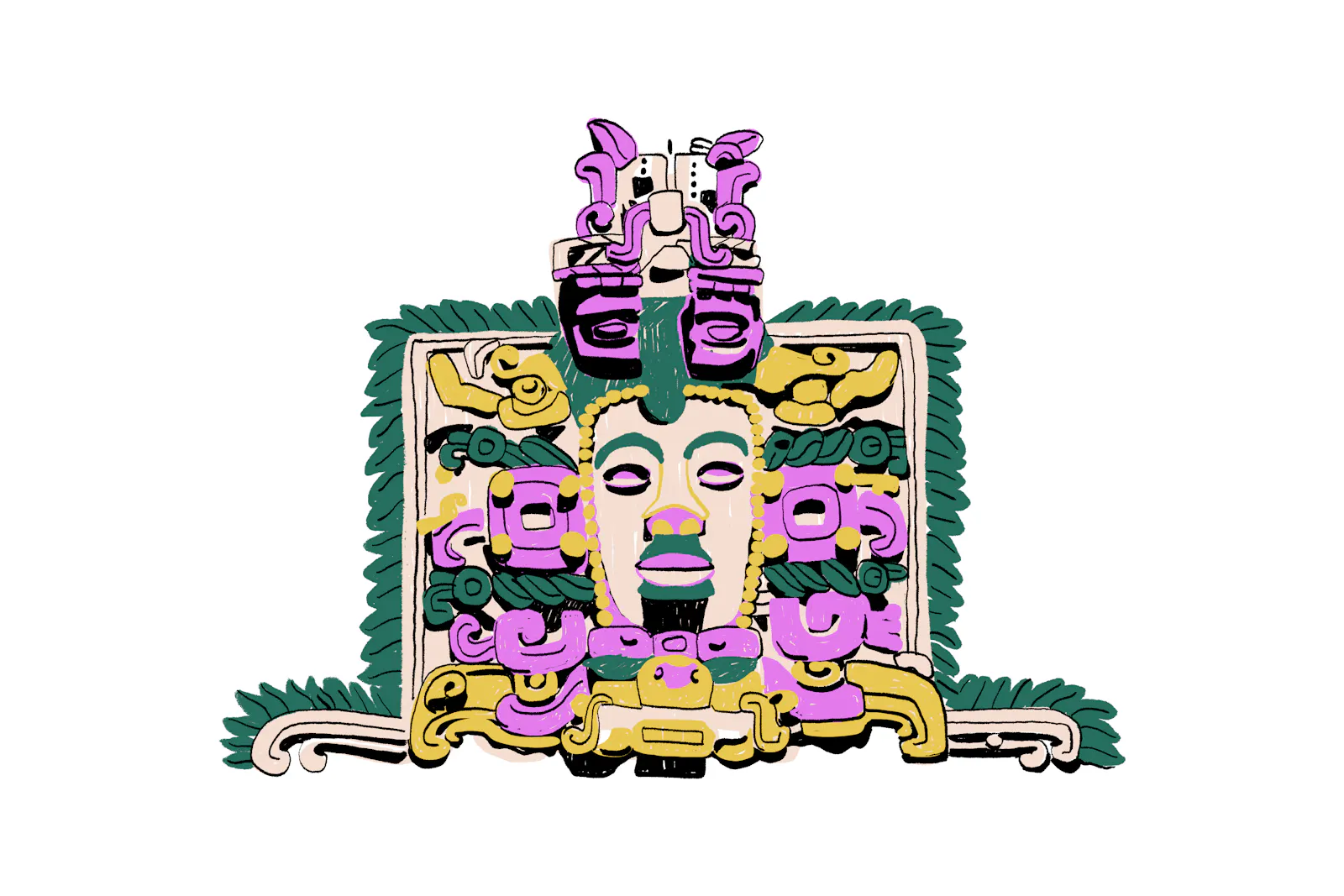
Albedo nasce da una necessità: capire e cercare di raccontare in tanti modi possibili i cambiamenti climatici e culturali che stiamo vivendo. Ragionando su quali potessero essere le parole più rappresentative dell’Antropocene, negli ultimi numeri mi sono interrogato sulla parola vulnerabilità. Cioè su come relazionarsi con questa condizione di fragilità, allo stesso tempo sia pubblica che privata.
Devo ammettere che in passato la prendevo con un certo prurito, a volte addirittura con un certo sgomento. Con il tempo - e in questo mi ha aiutato scrivere Albedo - mi sono accorto che soltanto una visione ossessivamente individualistica considera la vulnerabilità un attributo esclusivamente negativo: dal momento in cui nasciamo ogni singolo essere vivente è vulnerabile di fronte al flusso degli avvenimenti che gli possono accadere. Nascondere questo dato di fatto equivale a mistificare la nostra natura. Solo chi, al contrario, pensa di poter controllare tutto, fugge da questa condizione (con conseguenze sfavorevoli più o meno gravi).
Dopodiché la vulnerabilità mi è stata raccontata da Chiara, che è intervenuta con una mail il mese scorso. O meglio, la vulnerabilità e i suoi effetti benefici: lo stimolo alla trasformazione e alla metamorfosi (la quale, se ci va bene, può essere anche in meglio). E da qui ho iniziato a vedere la vulnerabilità come una fedele compagna di avventure, qualcosa che abbiamo appiccicato addosso e da cui potremmo trarne perfino una risorsa.
Per questo mese ho pensato di chiudere il cerchio (così magari nel frattempo tiriamo fuori qualche altra parola chiave) e di ritornare al me di qualche mese fa, cioè a quello che di perdere totalmente il controllo aveva un po’ paura. Ho detto di qualche mese, ma in realtà è di qualche anno. Esattamente al me del 2021, quando terminai di scrivere un racconto breve (estrapolato da un racconto ben più grande) su di un tizio, un certo Maurice Spikes, che si è trovato ad affrontare, con un certo senso di impotenza, uno degli uragani più intensi che abbia toccato suolo statunitense.
In questo racconto c’è della fiction, come è giusto che sia. Ma nemmeno poi così tanta, perché questo Maurice Spikes è realmente esistito, e questo uragano pure: è l’uragano Michael che nel 2018 ha toccato la costa occidentale della Florida.
Quando la stagione delle piogge entrò nel culmine, San Francisco Gotera si coprì d’acqua. Il rio Grande insieme a tutti i fiumiciattoli traboccò dai propri argini e inondò la valle. Osservai campesinos divertiti guardare le auto arrancare nei pantani: ridevano di gusto quando venivano colte da una tormenta e avanzavano a passi incerti per il sentiero fangoso, il quale diventava una vera e propria piscina con gorghi e vortici in corrispondenza dei punti dove le correnti rifluivano e si rimestavano. Le risate dei campesinos si mescolavano con il gorgoglio dei torrenti e il ticchettio della pioggia, il quale a volte durava per giorni interi e non si riusciva ad ascoltare altro che quel rumore, plic!plac!plic!.
Quel mese la zona costiera del Salvador fu devastata da una tempesta di inaudita violenza che obbligò la protezione civile a decretare l’allerta in quarantatre municipi; cosa che, però, non servì a granché visto che le raffiche di vento raggiunsero la velocità di 60 chilometri orari e crearono disagi un po’ ovunque. Il bollettino ufficiale del governo stimò che ci furono tre vittime (di cui due militari travolti dalla parete di una casa), quattordici feriti, nove strade ostruite o completamente rese inutilizzabili, una quantità impressionante di alberi divelti, sei fiumi straripati, cinquantasette frane e più di seicentosettantuno persone sfollate, le cui case si convertirono letteralmente in spazzatura. I divani, i letti, le fotografie affisse alle pareti, le cucine trascinate nel soggiorno dalla forza inarrestabile del fango: sembrava che in quelle case fosse entrato un gruppo di elefanti selvaggi.
Dopo il Salvador la tempesta tropicale proseguì, si placò, e poi si rafforzò nuovamente toccando il mare caldo del golfo del Messico, e si trasformò altrove in uragano. Huracán, il Cuore del Cielo, era il più grande tra gli Dei antichi, una divinità trina – formata a sua volta da Caculhá Huracán, il fulmine, Chipi Caculhá, il lampo, e Raxa Caculhá, il lampo verde – che secondo la cosmogonia centroamericana partecipò insieme a Tepeu e Gucumatz nell’opera di dar energia, respiro e vita alla Terra. Huracán era una divinità venerata dalle tribù mesoamericane perché era temuta, temuta perché rispettata, rispettata perché l’uomo era cosciente della sua minuscola insignificanza di fronte alle vastissime catastrofi generate dal creato.
La tempesta era nata originariamente a duecento miglia a nord di Panama e, a causa di alcuni venti altamente sfavorevoli, in Salvador aveva dato alcuni segnali premonitori dell’enorme distruzione che avrebbe arrecato altrove. Le raffiche di vento si spostarono verso nord ovest, risalirono il Pacifico, attraversarono l’istmo del Centro America fino alla penisola dello Yucatan e, passando per i tropici, si trasformarono in meno di due giorni in un uragano che si diresse verso la costa della Florida, a est di Panama City, in un tratto chiamato Panhandle, il quale è conosciuto dai locali con il nome di ‘costa dimenticata’ a causa della sua scarsa antropizzazione. In questa lingua di terra che ha quasi mille miglia quadrate di distese boschive, correndo lungo la statale, “si ha l’impressione di entrare in quel che resta di una Florida selvaggia, pre-Disney e pre-aria condizionata”, ha scritto un importante giornale statunitense. Insomma a pochi chilometri da quel segmento di costa, la sera del 10 ottobre 2018 l’ingegnere civile Maurice Spikes si ritrovò a condividere insieme ad altre 56 persone, tra aviatori e personale del servizio civile, una notte lunga e scomoda al secondo piano dell’edificio 909 della base dell’aeronautica militare di Tyndall, dove proprio in quel punto, di lì a qualche ora, sarebbe passato l’occhio del ciclone.
L'ordine di trasferirsi nell’edificio 909 l’aveva ricevuto il giorno precedente dal suo comandante. L’edificio in questione era considerato uno di quelli più robusti del complesso militare per via della sua armatura in acciaio e delle pareti interne in cemento. Il comandante aveva esortato Maurice e gli altri funzionari della base a stare tranquilli, avvisandoli che il ciclone sarebbe stato abbastanza lieve. Non poteva sapere che in poche ore - giusto il tempo della chiamata ai sottoposti e di consumare la cena con sua moglie e sua figlia - le temperature eccezionalmente alte della superficie marina del golfo del Messico, insieme a un’abbondante umidità atmosferica e a una buona dose di altre circostanze più o meno imprevedibili, convertirono un normale ciclone tropicale nel quarto uragano più forte che abbia mai colpito gli Stati Uniti continentali.
In seguito Maurice raccontò di non aver dormito per nulla durante quella notte. “Vedevo le pareti dell’edificio tremare” mentre raffiche di vento che viaggiavano a quasi trecento chilometri orari ne sferzavano l’inerme anima metallica. Improvvisamente l’antenna radio in cima all’edificio fu letteralmente sradicata da una folata, si udì un forte schianto e la membrana del tetto volò via lasciando le parti superiori della struttura scoperchiate ed esposte ai venti e alla pioggia, e fu in quel momento che chi si trovava rinchiuso al secondo piano dell’edificio 909 ebbe l’impressione che la distruzione sarebbe stata totale. “Rimasi spalla a spalla con altre 56 persone in uno spazio minuscolo, guizzando e sussultando a ogni fragore, eravamo tutti ansiosi di conoscere cosa ci aspettava dall’altra parte delle mura”. Il mattino seguente, una volta fuori, gli scampati non potevano credere ai loro occhi quando videro i tetti degli hangar completamente scoperchiati, e lì, a pochi chilometri, le case brutalmente strappate dalle loro fondamenta. Imponenti pali di calcestruzzo erano stati domati dall’uragano e mescolati a lamine di asfalto e altri detriti; e poco distante, là dove la sera precedente c’era una rigogliosa foresta di pini - i quali erano stati piantati quindici o venti anni prima con la speranza di poter raccogliere e utilizzare la loro poderosa legna, capace di vivere fino a cinquecento anni - esattamente in quel punto dove Maurice si ricordava ci fosse un rigoglioso pineto, cominciava un viaggio distopico attraverso distese di tronchi curvati dal vento, alberi spogliati della propria corteccia, dei propri rami e della propria corona, e un ammasso di boscaglia disperso alla rinfusa: ventitre milioni di metri cubi di schegge di legno sparse qua e là seguendo un ordine caotico, le quali stavano cominciando già a marcire sotto la luce del sole. Gli alberi che prima bordeggiavano la statale lungo la costa, di fronte l’Atlantico, adesso erano tutti monchi, spezzati a metà, ridotti a sottilissimi fiammiferi, come se durante la notte fosse passata di lì una scure infernale; e tra gli esemplari di pino giallo, pino taeda, aceri e querce, c’erano anche altre piantine più basse, più esili, che erano cresciute di fianco, all’ombra dei vegetali più nerboruti, e di cui erano rimaste solamente tracce invisibili all’occhio umano. Prima che arrivasse l’uragano, Maurice vi passeggiava spesso in quella foresta, confessò che quando il lavoro lo sovraccaricava camminare tra i pini lo faceva stare bene; ed è comprensibile che le forme slanciate e appuntite degli alberi e l’odore intenso di trementina lo commuovessero così facilmente, la loro seduzione nei confronti della nostra specie non è cosa recente, in realtà viene da molto lontano: all’odore penetrante della resina e alla malia della trementina ci hanno messo mano, seppur umilmente, le glaciazioni del periodo Quaternario, il primo organismo unicellulare a effettuare la fotosintesi, e così di seguito in un vortice all’indietro fino ad arrivare all’esplosione del big bang. È all’interno del nostro instabile corpo, quando ci innamoriamo o più semplicemente ci commuoviamo, che inavvertitamente rilasciamo piccolissime tracce dell’energia accumulata da questa terribile esplosione di tanto tempo fa. Cosicché quando Maurice vide tutta la distruzione percepì una sensazione di angoscia e di disagio difficile da spiegare. Quattro anni dopo, quando ritornò di nuovo nella base aeromilitare di Tyndall per assistere alla demolizione dell’edificio 909, confessò ad alcuni colleghi di sentirsi molto nervoso. Quello che crollava sotto i colpi di un’esplosione controllata era solo un vecchio edificio in cemento, ma “sentii una sensazione agrodolce al vederlo venir giù perché in fondo quell’edificio ci aveva salvato la vita”, disse.
Prima di concludere l’Albedo di maggio vorrei riportare un pensiero che mi ha scritto Luca, il caporedattore di Duegradi. Nello scorso numero si ragionava su quanto sia illusorio il concetto di progresso che ci siamo costruiti sulla scorta dei miglioramenti tecnologici. Pensare alla storia degli esseri umani come a una lunga evoluzione lineare tra uno stadio barbarico e un altro civilizzato è, nella migliore delle ipotesi, un’ingenuità; nella peggiore, una causa di razzismo.
Bene, a tutto ciò Luca ha aggiunto un altro tassello: “In merito alla evoluzione lineare mi sembra strettamente legato l’essere intrinsecamente ‘cristiani’ di noi Europei/occidentali. Vale a dire, nel cristianesimo il passato è sempre peccato, mentre il futuro è redenzione. Umberto Galimberti parte proprio da questo semplice assunto per far vedere che noi europei estendiamo questo approccio a tutti gli aspetti della vita e quello che ne deriva è che il passato è retrogrado, il futuro è progresso, il passato è lentezza, il futuro è dinamismo, il passato è composto da condizioni da cui emanciparsi, il futuro è il campo dove tale emancipazione potrà svilupparsi”.
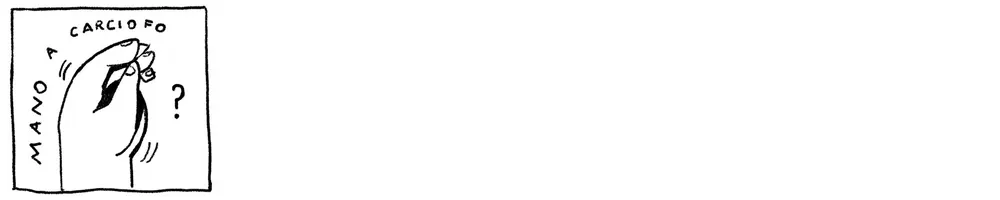
Rispondiamo alle vostre domande
Ecco, la contrapposizione passato/futuro potrebbe essere un altro tema per questa newsletter. Se avete qualcosa da dire a riguardo, comunicatemelo alla solita mail, redazione@duegradi.eu (Si apre in una nuova finestra) o sebastiano.santoro@duegradi.eu (Si apre in una nuova finestra). Noi siamo arrivati alla fine, l’editoriale di Albedo termina qui. Noi ci risentiamo il prossimo giugno. Vi invio un abbraccio virtuale.

Consigli di lettura
Il racconto di Maurice Spikes l’ho scritto due anni fa, ma inserirlo in Albedo pochi giorni prima della tremenda alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna mi ha fatto venire un brivido lungo la schiena. Su Repubblica, lo scrittore Gabriele Romagnoli ha tracciato un commovente ritratto (Si apre in una nuova finestra) delle terre devastate, che potrebbe essere una buona continuazione della storia di Maurice Spikes.
La crisi climatica c’entra con l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Ma chiedersi se esiste un legame di causalità diretto (Si apre in una nuova finestra) potrebbe essere riduttivo per comprendere il fenomeno dei cambiamenti climatici.
Reportage (Si apre in una nuova finestra) del Post dai luoghi colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna.
Come gli altri animali sopravvivono (Si apre in una nuova finestra) in ambienti estremi può insegnarci come vivere in un mondo più caldo.
L’Italia è ancora lontana (Si apre in una nuova finestra) dal raggiungere gli obiettivi climatici del 2030.
Secondo lo scrittore VandeerMeer la fiction climatica da sola non ci salverà (Si apre in una nuova finestra).
“Sostengo i sabotatori che hanno agito con coraggio e coerenza, ma non farò saltare in aria (Si apre in una nuova finestra) un oleodotto”, riflessioni sull’uso della violenza nei movimenti ambientalisti.
ENI è stata citata (Si apre in una nuova finestra) in giudizio da Greenpeace e Recommon.
Più dighe costruiamo, più i fiumi smetteranno (Si apre in una nuova finestra) di trasportare sabbia, terra e altro materiale solido negli oceani.
Sulla newsletter Medusa, Alessio Giacometti afferma (Si apre in una nuova finestra) che “scrivere di crisi climatica [...] significa oggi situarsi tra gli ecologismi, collocarsi cioè rispetto a precisi immaginari socio-ambientali di futuro, in conflitto tra loro”.

Lavoro e formazione
La scuola estiva Eu-Med Climate organizzata da Roma Tre arriva alla sua seconda (Si apre in una nuova finestra) edizione.
A Padova Etifod, un’azienda specializzata in consulenza ambientale, è alla ricerca di un/a Communication Specialist (Si apre in una nuova finestra).
Solo per giornalisti iscritti all’albo: il 26 maggio a Udine, dalle 9 alle 13, si tiene un corso di formazione gratuito con l’ufficio del Parlamento Europeo in Italia sul tema “Unione Europea e giornalismo locale e nazionale. Politiche ambientali come scoprirle, come raccontarle”. Ci si iscrive dalla piattaforma Formazionegiornalisti.it (Si apre in una nuova finestra). Eroga 4 crediti. Una volta che ci sei dentro, il link del corso è questo (Si apre in una nuova finestra).
L’agenzia di notizie Reuters cerca un reporter (Si apre in una nuova finestra) specializzato in tema energia e fonti rinnovabili.
Da tenere sempre a mente che il 27 luglio 2023 (Si apre in una nuova finestra) scade l’Investigation Grants for Environmental Journalism.

Riflessi: qualche numero dal pianeta Terra
6 trilioni di Dollari americani,
i fondi che sarebbero necessari da qui al 2030 per finanziare i Contributi determinati a livello nazionale (o NDC, Nationally Determined Contributions) dei paesi in via di sviluppo al fine di raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Nel 2020, solo 250 miliardi hanno raggiunto questi paesi.
Ci vediamo il mese prossimo!


