Imparare Facendo alla Trappa
Pubblico parte della mia introduzione al libro per ricordarvi dell’appuntamento di domani alle 15 alla Trappa di Sordevolo (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Vi aspetto
Ettore
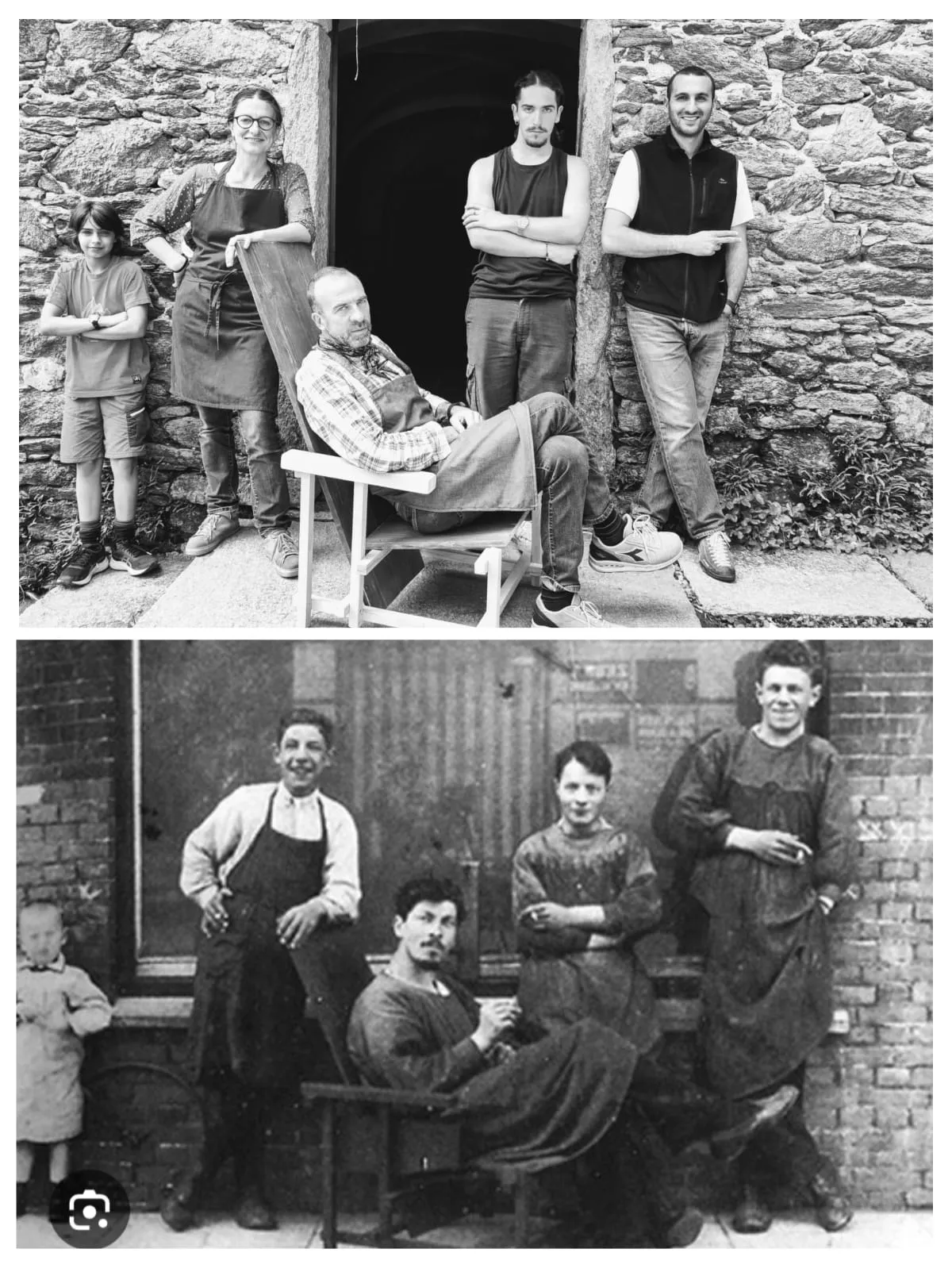
Riparare il mondo iniziando dalla Z
di Ettore Macchieraldo
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in famme al largo dei bastioni di Orione,e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo,come lacrime nella pioggia.
Citazione dal flm Blade Runner di Ridley Scott, 1982
Se c’è un film che rappresenta la critica all’istituzione scuola della mia generazione, la generazione X, quello è certamente l’Attimo Fuggente, uscito nelle sale italiane nel settembre del 1989. Era per me l’ultimo anno di superiori; mi erano, infatti, piaciute così tanto che, ai cinque anni canonici, ne avevo voluto, a tutti i costi, aggiungerne un sesto.
Quel film piacque a noi studenti, meno agli insegnanti perché rappresenta molto bene l’aspirazione alla trasgressione degli adolescenti e la necessità, per crescere, del gruppo dei pari, che si contrappone agli adulti. Un’aspirazione rappresentata bene dal regista australiano Peter Weir, interpretata magistralmente dai giovani protagonisti e da Robin Williams, il loro maestro.
Il titolo della traduzione italiana riprende la poesia di Orazio “Carpe diem”, cogli l’attimo. La vera aspirazione di ogni giovane prima di Greta Thunberg, la ragazza che iniziò gli scioperi del venerdì per denunciare il furto del futuro suo e dei suoi coetanei, uscendo dal vivere l’immediatezza del momento per, invece, denunciare le cause e ricercare le soluzioni del disastro ambientale.
Il flm che meglio coglie questo passaggio, però, è del 1992 ed è di un regista argentino. Si tratta de El Viaje di Pino Solanas. La prima sequenza inizia proprio in una scuola “nel buco del culo del mondo”, in Patagonia, nella Terra del fuoco. È la scuola frequentata dal protagonista, il giovane Martin, dove vigono regole insensate, ripetute dagli adulti come uno stanco rituale, mentre nevica dentro l’edifcio e crollano uno a uno i quadri che rafgurano i Padri della Patria. Nelle prime scene, sempre nella scuola svuotata e senza senso, una professoressa di scienze spiega al solo Martin, stancamente adagiato sul banco, i cambiamenti climatici.
Ricordo che allora eravamo in pochi a parlarne e ci è voluto almeno un decennio perché divenissero argomento dell’agenda internazionale.
Nel libro che è nelle vostre mani di questo tema si occupa Giuseppe Paschetto, offrendo alla causa ambientale tutta la sua esperienza di docente.
Nei primi scritti di presentazione di Imparare Facendo, il seminario che è all’origine di questa raccolta di testi, ho usato l’appellativo Gretini riferendomi alla Generazione Z, quella delle mie figlie.
Gretini è il nomignolo dispregiativo che Vittorio Feltri, direttore di "Libero", de “Il Giornale” e opinionista televisivo, coniò per i ragazzi che seguirono Greta Thunberg nella denuncia dello sperpero di risorse della generazione di Feltri e delle successive, perpetrato ai danni dei gretini, dei loro coetanei e di tutto l’ambiente naturale.
Questa pesante eredità fa sì che il Carpe Diem sia difficilmente realizzabile dai giovani di oggi. Quantunque possano essere impantanati in “un eterno presente che capire non sai”, tanto da rimanerne invischiati fino a togliergli il respiro, quella che hanno di fronte è comunque la guerra per accaparrarsi le risorse oppure, più auspicabilmente, l’equa e pacifica gestione di esse, non certo la spensieratezza della Setta dei poeti estinti.
La condizione dei preadolescenti e degli adolescenti è stata l’argomento principale della giornata che abbiamo organizzato con mia sorella Grazia in memoria dei nostri genitori a Viverone, in Provincia di Biella, nella stessa scuola elementare che frequentarono le mie fglie e in cui, per altri anni successivi, ho fatto il volontario per la mensa e il doposcuola.
Con i giovani di oggi ho a che fare quotidianamente. Non solo sono padre di due adolescenti, ma conduco laboratori, fuori e dentro la scuola, di autocostruzione e, per non farmi mancare niente, sono anche operatore locale di progetto per il servizio civile universale.
L’opinione che ho dei giovani di oggi è che li abbiamo cacciati in un vicolo cieco. Non sono loro inadatti, siamo stati noi, e le generazioni che ci hanno preceduto, ad aver creato questa miscela di mancanza di futuro e, al contempo, di continua necessità di misurarsi con le performance.
Se c’è un periodo storico in cui sarebbe stato possibile cambiare strada, uscire dalla logica del ciclo “produci/consuma/crepa” o, per essere meno punk, dal modello estrattivo, quelli furono gli anni ‘60 del secolo scorso. Robert Kennedy, non John Fitzgerald ma suo fratello, lo espresse molto chiaramente nel suo discorso all’università del Kansas nel marzo del 1968.
Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell’ammassare senza fne beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del Prodotto Nazionale Lordo (PIL).
Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrarele nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti.
Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi. Il Pil non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese.
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere Americani.
Direi che, dato tutto ciò che è avvenuto dopo, Robert non sarebbe affatto orgoglioso di essere americano.
I genitori di Grazia e miei furono parte di quella possibile alternativa. I sistemi educativi che questo libro promuove, sono strettamente legati al meglio di quelle esperienze. Non solo alla Società Umanitaria dove Maria e Domenico si conobbero,
ma anche alla Scuola di Barbiana, all’esperienza di Mario Lodi, alla maieutica di Danilo Dolci e alla grande conquista sindacale del contratto dei metalmeccanici del 1973. Mi riferisco alle 150 ore di cui parla anche Andrea De Lotto nel suo intervento che vi accingete a leggere. Tutte esperienze da guardare con rispetto, che ritrovo anche nel racconto di Giampiero Monaca e della sua assurda esclusione dall’ambito della scuola pubblica. Un allontanamento ancora più incomprensibile se si pensa a cosa è stata la scolarizzazione nel nostro paese.
In Italia, limitandosi a leggere il fenomeno negli anni ‘60 e ‘70 del 900, è avvenuta una “socializzazione” della scuola, un po’ l’incontrario della descolarizzazione della società che proponeva Ivan Illich, ma l’effetto cercato era simile: l’abbattimento della disuguaglianza sociale e la conquista della autodeterminazione dei percorsi di vita dei singoli e delle comunità. [... ]
Sono talmente intriso di quella democrazia radicale dei Settanta che, nella mia ricerca sull’autocostruzione, sono partito dal manuale "Autoprogettazione?" (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) di Enzo Mari. Fu designer, per quanto poco stimasse la categoria, fece altresì la sua prima breve esperienza come insegnante proprio alla Società Umanitaria di Milano. Nel 1974 realizzò una mostra di oggetti e un catalogo/manuale partendo dal fallimento del suo divano letto Day and night. Commissionato da De Padova e prodotto da Driade, rimase invenduto. Mari mise a fuoco con quel fallimento la mancanza di cultura dell’oggetto da parte del nuovo soggetto sociale: i consumatori.
In fondo, si tratta della presa di coscienza della perdita della cultura materiale di provenienza delle persone emigrate in città, quella stessa cultura che Giuseppe Pidello, coordinatore dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, chiama “le competenze degli abitanti”.
Enzo Mari sostenne, infatti, che il contadino che pianta un bosco di castagni è un buon designer perché, pur se non potrà mangiare le prime castagne, né potrà utilizzare il legno, né in agosto godere dell’ombra di un grande albero, lo potranno fare, però, i suoi nipoti.
Quanta distanza c’è con il “tutto e subito” del “qui e ora” che viviamo oggi nel quotidiano?
[...]


